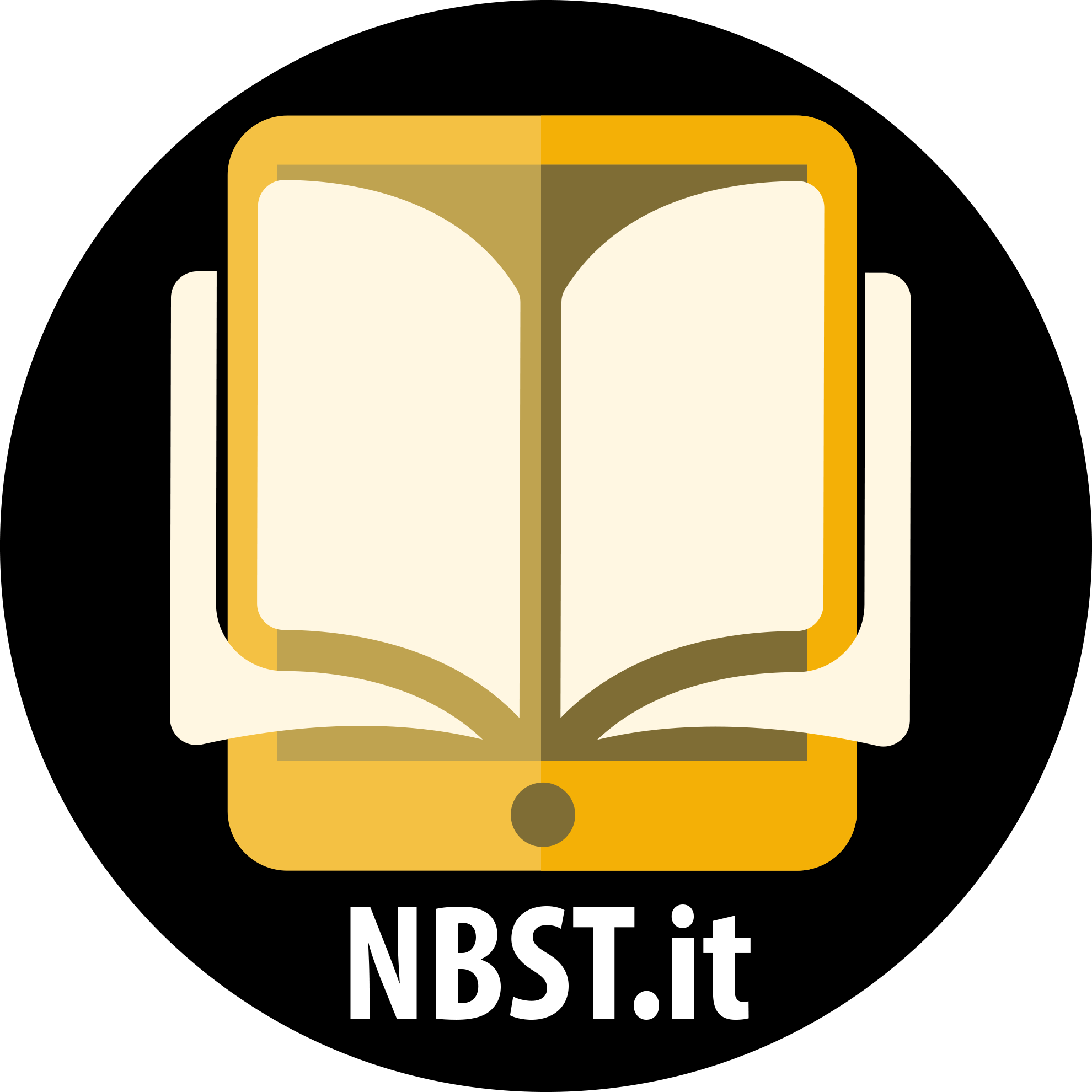E’ stato pubblicato il 19 agosto 2020 su
Leukemia l’articolo dal titolo
Compassionate use of JAK1/2 inhibitor ruxolitinib for severe COVID19: a prospective observational study.
Lo studio, condotto da Vannucchi e colleghi presso l’
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, aveva come obiettivo principale quello di riportare gli outcome dei pazienti con gravi manifestazioni respiratorie da COVID-19 arruolati in uno studio osservazionale prospettico nell’ambito di un protocollo per uso compassionevole di
Ruxolitinib (inibitore dell’attività di JAK1/JAK2 appartenenti alla famiglia delle Janus Kinasi, interferendo in tal modo con la via di trasduzione del segnale alle citochine e pertanto con potenti proprietà antinfiammatorie).
Il 2 aprile 2020 è stato approvato, dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dall'Istituto Spallanzani, un protocollo di trattamento per l'uso compassionevole di ruxolitinib in pazienti con infezione da SARS-CoV-2, per un massimo di 28 giorni. I pazienti eleggibili allo studio erano:
- positivi al test di reazione a catena della polimerasi (PCR) su tampone nasofaringeo o su un campione del tratto respiratorio inferiore
- con gravi manifestazioni da COVID-19 (definite dalla presenza di infiltrati polmonari all'imaging più una saturazione di ossigeno ≤93% nell'aria ambiente e/o un rapporto pressione parziale di ossigeno arterioso (PaO2)/frazione di ossigeno inspirato (FiO2)≤300 mmHg).
Il Ruxolitinib è stato somministrato a una dose giornaliera iniziale di 5 mg due volte al giorno, la dose è stata aumentata a 10 mg due volte al giorno dopo 24-48 h nel caso in cui non vi fosse alcun miglioramento della funzione respiratoria e/o supporto di ossigeno rispetto al basale. E’ stato consentito un ulteriore aumento a 25 mg al giorno dopo ulteriori 48 ore. I pazienti hanno potuto ricevere qualsiasi altra terapia disponibile per COVID-19, come da protocolli istituzionali.
Presso l’Azienda ospedaliera-universitaria Careggi di Firenze, dal 7 aprile all'8 maggio 2020, sono risultati eleggibili per lo studio 40 pazienti. Di questi, 6 non hanno ricevuto il trattamento a causa del peggioramento della trombocitopenia (1 paziente), della revoca del consenso (1 paziente), del passaggio precoce all'intubazione (1 paziente) e della morte precoce (3 pazienti). Dei 34 (52,9% maschi; l'età mediana di 80,5 anni) che hanno ricevuto almeno una dose di ruxolitinib, 29 pazienti (85,3%) sono stati dimessi entro il periodo di osservazione di 28 giorni; 2 pazienti (5,8%) sono morti, 3 pazienti (8,9%) erano ancora ricoverati entro il 28° giorno. L’85% dei pazienti presentavano comorbidità tra cui ipertensione, diabete, cardiopatia cronica, malattia polmonare, malattia renale cronica, cancro, malattie neurologiche, malattia autoimmuni. In base al SOFA (sepsis-related organ failure assessment) score, che descrive la disfunzione/insufficienza d'organo: 1 paziente presentava 0-1 punto, 23 pazienti 2-3 punti, 10 pazienti 4-5 punti.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei pazienti durante il trattamento, è stato osservato un miglioramento del profilo delle citochine infiammatorie e dei sottogruppi di linfociti attivati. L’incidenza cumulativa del miglioramento clinico di ≥2 punti nella scala ordinale è stata riscontrata nell'82,4%. Tale miglioramento clinico non è stato influenzato dal supporto di ossigeno a basso flusso vs quello ad alto flusso, ma risultava meno frequente nei pazienti con PaO2/FiO2 <200 mmHg. Gli eventi avversi più frequenti sono stati anemia, infezioni del tratto urinario e trombocitopenia.
La sopravvivenza globale al 28° giorno è stata del 94,1%. Sebbene siano necessari ulteriori studi clinici controllati per stabilire l'efficacia di ruxolitinib nel COVID-19, gli autori concludono che l'uso compassionevole di ruxolitinib si associava al miglioramento della funzione polmonare e alla dimissione domiciliare nell'85,3% di pazienti anziani con comorbidità e ad alto rischio per COVID-19 grave.